Orazio: il figlio di un liberto alla corte di Augusto
Di umili origini, ma di buona condizione economica, sostenne la figura e la politica dell'imperatore Ottaviano
Le origini di Orazio
Quinto Orazio Flacco nacque a Venosa, una strategica colonia romana tra Apulia e Lucania nell’odierna Basilicata, l’8 dicembre del 65 a.C. Suo padre – cui esprimerà tutta la propria gratitudine in un tributo nelle Satire – fu un fattore liberto che si trasferì nell’Urbe per fare l’esattore delle aste pubbliche, una mansione estremamente redditizia: il poeta, pertanto, pur di umili origini, crebbe in una buona condizione economica, ricevendo le prime nozioni di favolistica dalla nutrice Pullia. Dopo aver trascorso l’infanzia nella sua città natale, seguì dapprima un regolare corso di studi a Roma, sotto l’insegnamento del grammatico Orbilio, e poi – intorno ai vent’anni – si trasferì ad Atene, dove ebbe modo di apprendere il greco e dedicarsi alla filosofia presso Cratippo di Pergamo. Fu proprio qui che entrò in contatto con la lezione epicurea ma, nonostante il fascino e l’attrazione che aveva su di sé, decise di non aderirvi, almeno in un primo momento. Lo farà successivamente, dopo il suo ritorno a Roma, trovando così rifugio nell'”otium contemplativo”. Tuttavia, allo scoppio della guerra civile sorta a seguito della morte di Giulio Cesare, Orazio si arruolò nell’esercito di Bruto, nel quale il poeta incarnò il proprio ideale di libertà in totale antitesi rispetto alla tirannia dell’autorità imperiale. Combatté quindi, come tribuno militare, nell’esercito repubblicano comandato da Bruto, partecipando alla battaglia di Filippi del 42 a.C., vinta però dall’esercito rivale, quello di Marco Antonio e Ottaviano. Durante lo scontro persero la vita lo stesso Bruto e Cassio, mentre Orazio si diede alla fuga al termine del secondo combattimento, come da egli stesso confessato in una delle sue odi, in cui raccontò di essersi ritrovato di fronte a situazioni molto pericolose.
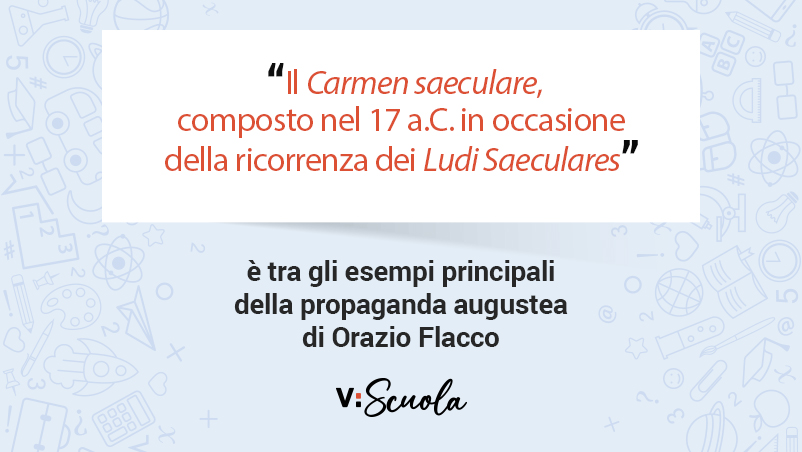
La poesia e il sostegno ad Augusto
Nel 41 a.C. Orazio fece nuovamente ritorno in Italia grazie a un’amnistia e, dopo aver appreso la notizia della confisca del podere paterno, riuscì a mantenersi accettando il ruolo di segretario di un questore (lo ‘scriba quaestorius’). Fu proprio in questo periodo che iniziò a scrivere i suoi primi versi, che contribuirono a conferirgli una discreta notorietà. Un triennio più tardi, poi, Virgilio e Vario, che aveva probabilmente incontrato grazie alle sue frequentazioni presso le scuole epicuree di Sirone presso Napoli ed Ercolano, venne presentato a Mecenate, il quale, dopo nove mesi, lo ammise nel suo circolo. Tale gesto cambiò la vita di Orazio, perché da quel momento poté dedicarsi interamente alla letteratura, nonostante le precarie condizioni dei suoi occhi, fortemente indeboliti a causa di una congiuntivite, soprattutto alla luce del fatto che non si sposò mai, né ebbe figli. Ad ogni modo, nel 33 a.C., Mecenate gli fece dono di un piccolo possedimento in Sabina, le cui rovine sono ancora oggi visitabili nei pressi di Licenza, in provincia di Roma. L’offerta fu cosa particolarmente gradita al poeta in quanto, in perfetta osservanza del ‘modus vivendi’ predicato da Epicuro, era tutt’altro che attratto dall’idea di trascorrere la propria esistenza in città. Sfruttando la grande libertà compositiva che Ottaviano Augusto – almeno all’inizio, salvo poi invertire la rotta, come testimoniato dalla vicenda biografica di Ovidio, dopo la morte di Mecenate – lasciava ai poeti, Orazio mise la propria arte ‘a disposizione’ dell’imperatore, sostenendo la sua figura e la sua abilità politica. Tra gli esempi principali della propaganda augustea dell’autore di Venosa ci sono alcune Odi e il ‘Carmen saeculare’, composto nel 17 a.C. in occasione della ricorrenza dei ‘Ludi Saeculares’. La morte, invece, sopraggiunse il 27 novembre dell’8 a.C. e dopo la sua dipartita venne sepolto sul colle Esquilino, accanto al suo amico Mecenate, che era passato a miglior vita soltanto due mesi prima.
