Tacito e il potere: critica sulla corruzione dell’Impero
Visse in un'epoca di grande splendore e, al tempo stesso, di forti tensioni sociali e politiche, che seppe descrivere abilmente coniugando le nozioni da storico con la sensibilità tipica dello scrittore
- Il contesto storico
- 'De vita et moribus Iulii Agricolae', 'De origine et situ Germanorum' e 'Annales'
Il contesto storico
Della vita di Cornelio Tacito sappiamo pochissimo. Persino il suo prenomen, probabilmente Publio, ma secondo alcuni Gaio, è incerto. Si pensa fosse nativo della Gallia Narbonese, il cui cognomen era piuttosto diffuso, anche se il futuro imperatore Claudio Tacito (che regnò nel 275 e nel 276), originario di Terni, si vantava di essere un suo discendente. Tacito, ad ogni modo, era il suocero del comandante Giulio Agricola, del quale sposò la figlia, ebbe la miglior educazione possibile (si dice sia stato allievo di Quintiliano) e intraprese presto la carriera politica, percorrendo il ‘cursum honorum’: la sua attività iniziò con Vespasiano e proseguì fino al giorno della sua morte, tra il 116 e il 122. Visse in un’epoca della storia romana di grande splendore ma, al tempo stesso, di forti tensioni e conflitti sociali e politici e la grandezza di Tacito fu quella di descriverla abilmente, coniugando le nozioni da storico con la sensibilità tipica dello scrittore. Al momento della sua nascita, intorno al 55, la repubblica era terminata da tempo, eppure lui si considerò sempre un erede diretto di quella particolare forma di governo: affermò, infatti, che le virtù di Roma erano quelle antiche, andate ormai irrimediabilmente perdute. Dai suoi testi, del resto, emerge un dettagliato dipinto dei potenti, una serie di imperatori definiti crudeli, immorali e corrotti. Nostalgico, ma anche realista, era consapevole del fatto che la restaurazione delle istituzioni repubblicane sarebbe stata rovinosa e che il principato, di fatto, si era trasformato in una necessità, all’interno di un contesto in cui, nonostante forza, lusso e sfarzo fossero ‘qualità’ comuni, la ricchezza inesauribile, i commerci fiorenti e le armate imperiali invincibili, si avvertivano i primi scricchiolii di una crisi imminente, soprattutto da un punto di vista morale.
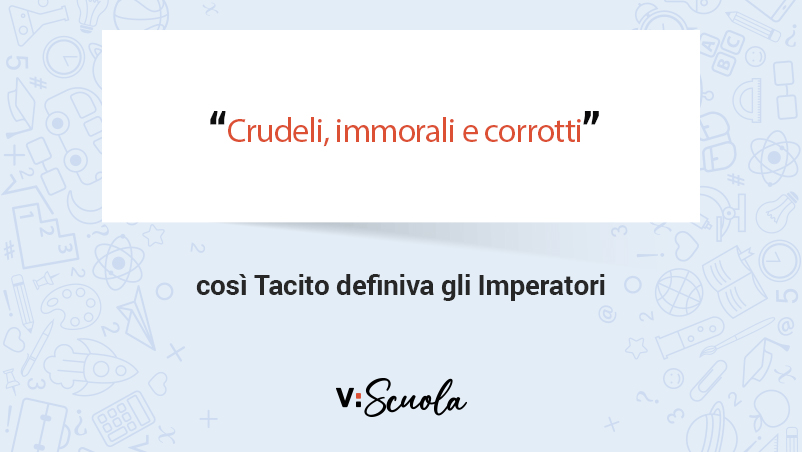
‘De vita et moribus Iulii Agricolae’, ‘De origine et situ Germanorum’ e ‘Annales’
Il ‘De vita et moribus Iulii Agricolae’ è un’opera scritta attorno al 98, in seguito alla morte dell’imperatore Domiziano, in cui viene descritta la vita del suocero, Gneo Giulio Agricola, governatore della Britannia. Tacito mette a confronto la libertà e il coraggio dei Britanni con la corruzione e la tirannia che – a suo parere – stanno mettendo in ginocchio l’Impero. Attacca, inoltre, l’avarizia dei Romani e per farlo si serve dell’espediente del discorso, attribuito a Calgaco, capo dei Caledoni, popolazione dell’attuale Scozia, con cui fu combattuta – nell’83 o nell’84 – la battaglia del monte Graupio. Analogamente a quanto fatto nel ‘De vita et moribus Iulii Agricolae’, nel ‘De origine et situ Germanorum’, anch’esso scritto probabilmente nel 98, Tacito, elogiando l’integrità dei costumi dei Germani, rivolge di riflesso un durissimo attacco a quelli romani, che considera degenerati. Negli ‘Annales’, poi, la sua opera finale che segue la composizione delle ‘Historiae’ e che risale verosimilmente agli anni seguenti il suo proconsolato d’Asia (112-113), accentua le disarmonie, riflettendo l’ambiguità degli avvenimenti e un moralismo sempre più pessimistico. Si tratta di un insieme di libri, sedici o forse diciotto, di cui sono giunti fino ai giorni nostri i primi quattro, l’inizio del quinto, il sesto privo dei capitoli iniziali e l’undicesimo e il sedicesimo con alcune lacune: si focalizzano sui meccanismi dell’Impero e sulla sua corruzione, con protagonisti i singoli ‘princeps’, opposti al Senato, erede della ‘libertas’ repubblicana, ridotta ormai a un mero nome senza peso politico. Le figure dei tiranni sono indagate con introspezione psicologica: ad esempio, Tiberio è descritto come l’emblema della falsità e della dissimulazione nel presentare il proprio potere come rassicurante continuazione della legalità repubblicana, Claudio come un inetto privo di volontà, manovrato dai liberti e dalle donne di corte, e Nerone come un uomo senza scrupoli, la cui follia sanguinaria non risparmia né la madre Agrippina minore né il suo antico consigliere Seneca. Come detto, pur convinto della necessità storica del principato fondato da Augusto, analizza come esso abbia svuotato le magistrature repubblicane da ogni potere, lasciando spazio a corruzione, intrighi e decadenza morale, cui hanno contribuito una politica di degrado e l’avidità di potere, che coinvolgono anche lo stesso Senato, diviso fra servilismo e sterili atteggiamenti di opposizione. Anche se una parte benestante della classe politica continuava ad esercitare onestamente il proprio potere sulle province e a guidare l’esercito in modo retto, secondo Tacito tutte le classi sociali, senza eccezione alcuna, mostravano ambizione, brama di potere e di prestigio personale, invidia, ipocrisia e presunzione.
