Guido Gozzano: il poeta sensibile tra eleganza e malinconia
Tra gli ispiratori dei Crepuscolari, l’autore torinese si è contraddistinto per una lirica inimitabile, aulica e prosaica, e per la sagace ironia che gli ha permesso di scherzare con la morte
Spesso incluso nel movimento dei Crepuscolari, il torinese Guido Gozzano, pur restandone tra i massimi ispiratori, si è contraddistinto per una poetica inimitabile e non riconducibile, capace di far convivere l’aulico e il prosastico, il lirico e il prosaico, grazie al distacco garantito dalla sua pervasiva ironia.
Poeta della “malinconia”, delle “buone cose di pessimo gusto” e del “ciarpame reietto”, Gozzano vive un’esistenza breve e in buona parte condizionata dalla convivenza con la malattia, che ne accresce l’innato disincanto, senza mai sfociare in disperato vittimismo e senza mai intaccare l’eleganza dei suoi versi e l’acume della sua prosa.
La vita
Guido Gustavo Gozzano nasce a Torino il 19 dicembre 1883. La sua è una famiglia borghese benestante, il padre è Fausto, ingegnere e costruttore, sposato in seconde nozze con la giovane Diodata Mautino, figlia di un patriota mazziniano, appassionata di teatro e attrice dilettante.
Trascorsa l’infanzia tra Torino e Agliè Canavese, nella villa di famiglia del Meleto, a neanche 18 anni perde il padre per una polmonite. Il giovane Guido ama scrivere versi, prevalentemente di impronta dannunziana, ma non è uno studente brillante, si diploma a fatica e si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, che però non frequenta quasi mai, maggiormente attratto da quella di lettere e dalle lezioni di Arturo Graf, in particolare quelle riguardanti la Divina Commedia, che segue assiduamente. Intanto entra a far parte della “Società di cultura”, un circolo formato da intellettuali del calibro di Luigi Einaudi, Guglielmo Ferrero e Gaetano Mosca, ma che Gozzano vive in maniera più leggera, preferendo la goliardia ai seriosi intenti pedagogici del gruppo. E’ in questi anni però che ultima la raccolta intitolata “La via del rifugio”, contenente trenta poesie e pubblicata nel 1907, e fa la conoscenza di Amalia Guglielminetti, scrittrice e poetessa con la quale intreccia una tenera ma tormentata storia d’amore, testimoniata da un fittissimo scambio epistolare.
Proprio nel momento in cui la sua notorietà inizia ad allargarsi, però, gli viene diagnosticata una lesione polmonare all’apice destro, è la sinistra avvisaglia della tubercolosi che se lo porterà via, nonostante i tentativi di rallentarne l’aggravarsi attraverso lunghi periodi trascorsi in località marine.
Lasciati definitivamente gli studi giuridici per dedicarsi totalmente alla poesia, nel 1911 pubblica il suo capolavoro, “I colloqui”, una raccolta di 24 componimenti poetici divisa in tre sezioni Il giovenile errore, Alle soglie e Il reduce, che gli vale non solo un grande successo di critica, ma anche la prestigiosa collaborazione con La Stampa.
Proprio per il quotidiano torinese scriverà le sue Lettere dall’India, composte durante il disperato viaggio a Bombay in compagnia dell’amico Giacomo Garrone per cercare di arrestare l’incedere della malattia, che verranno raccolte nel volume “Verso la cuna del mondo”.
Tornato dall’oriente inizierà a lavorare sul poemetto Farfalle, del quale verranno pubblicati però solo pochi frammenti e che resterà incompiuto per il sopraggiungere dell’“ora del triste congedo”, a neanche 32 anni, il 9 agosto del 1916.
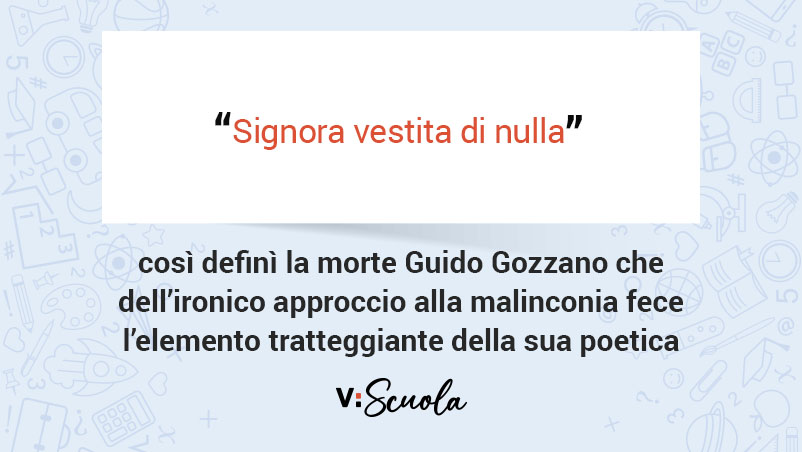
L’inimitabile poetica
Cultore del dandysmo come D’Annunzio, Gozzano è stato però protagonista di una poetica che sin dall’inizio è parsa contrapposta a quella del “vate” pescarese, caratterizzata dalla religione del bello e atteggiamenti esibiti. Al contrario, il poeta torinese finge di accogliere i valori borghesi e intanto rovescia i miti del dannunzianesimo, raccontando “la vergogna di essere poeta” mentre esalta “commercialmente” la bellezza quale valore irrinunciabile per l’uomo, o simulando “aridità sentimentale” mentre canta amori improbabili con cocottes e servette, intrecciando aulico e prosaico in una consapevole scelta estetica. Spazi domestici, soffitte polverose, personaggi miseri, salotti pettegoli e bigotti sono i miti antidannunziani che Gozzano costruisce per evadere dalla realtà di una vita borghese, in una Torino borghese, chiusa e profondamente provinciale, ma anche intima e consolatrice meta dell’animo del poeta.
Esteta disincantato e melodrammatico, nelle sue liriche sfiora continuamente la parodia, cantando ed estetizzando il quotidiano attraverso ritratti minuziosi ed evocando la malinconia delle cose perdute.
Sagace dissacratore degli amori e delle pose da esteta di D’Annunzio, eppure suo ammiratore, Gozzano sintetizza questi paradossali sentimenti interpretando il ruolo di Totò Merumeni, uno dei sui alter ego presenti ne “I colloqui”, che solo, in una villa decadente dal giardino incolto, si lascia andare al ricordo di un passato definitivamente scomparso sotto l’incedere del tempo, costretto a “vender parolette” per tirare avanti e che ha scelto l’esilio, rinunciando a un sogno d’amore per ritrovarsi in compagnia di una ghiandaia roca, un gatto e una bertuccia di nome Makakita.
L’elemento malinconico dello scorrere del tempo e delle occasioni perdute che non torneranno, trova poi la sua massima espressione nei celebri versi della Cocotte, in netto e consapevole contrasto con il carpe diem oraziano, “non amo che le rose che non colsi. Non amo che le cose che potevano essere e non sono state”, ispirati all’“Ode su un’urna greca” di Keats, “sì le melodie ascoltate son dolci; ma più dolci le non ascoltate”.
E’ però l’ironico approccio alla malinconia l’elemento tratteggiante della poetica di Gozzano, che trova la sua esaltazione proprio nel rapporto con la morte, la “Signora vestita di nulla”, indesiderata compagna di strada del poeta, che anziché esorcizzarla, la accoglie con disincanto: “Io non gemo, fratello, e non impreco:/ scendo ridendo verso il fiume oscuro/ che ci affranca dal Tempo e dallo Spazio. Precettore di un’incomparabile ars moriendi”.
