L'eredità di Marx: il Marxismo e le influenze nel XX e XXI Secolo
La filosofia marxista può essere divisa in marxismo occidentale, nato all'indomani della rivoluzione del 1917 in Russia e dell'ascesa del leninismo, e materialismo dialettico, considerato la "filosofia ufficiale" dell'Unione Sovietica
Il marxismo occidentale
Il marxismo occidentale – termine utilizzato per la prima volta in modo sprezzante a partire dalla Terza Internazionale nel 1923 – è una corrente della filosofia marxista sviluppatasi in Europa occidentale e centrale all’indomani della Rivoluzione russa del 1917 e della conseguente ascesa del leninismo. I teorici di questa branca filosofica risultano meno interessati all’analisi economica rispetto alle precedenti scuole di pensiero marxista, mentre preferiscono porre maggiore enfasi sullo studio delle tendenze culturali della società capitalista, dispiegando così gli aspetti più filosofici e soggettivi del marxismo e incorporando, al contempo, approcci non marxisti all’indagine sulla cultura e sullo sviluppo storico. Sebbene le prime figure, come György Lukács e Antonio Gramsci, abbiano avuto un ruolo di primo piano nelle attività politiche, dagli anni Sessanta il concetto è stato strettamente associato alla New Left (Nuova Sinistra). Molti marxisti occidentali aderivano all’umanesimo marxista, ma emersero anche figure e scuole di pensiero fortemente critiche nei confronti dell’hegelismo e dell’umanesimo stesso, definiti marxisti strutturali (su tutti Louis Althusser e Nicos Poulantzas). Intorno alla metà del decennio successivo, invece, Perry Anderson confinò il marxismo occidentale post-Seconda Guerra Mondiale principalmente nel mondo accademico: emersero così altri autori di spicco legati a questa corrente, quali Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Galvano della Volpe. Ad ogni modo, Perry Anderson osservò che la tradizione nacque dal fallimento delle rivoluzioni proletarie in varie società capitaliste avanzate nell’Europa occidentale – in primis Germania, Austria, Ungheria e Italia – a seguito della Prima Guerra Mondiale. Per lo storico, sociologo e saggista britannico il marxismo occidentale altro non fu che un divorzio tra teoria socialista e pratica della classe operaia derivante dalla sconfitta e dalla stagnazione della classe operaia occidentale dopo il 1920.
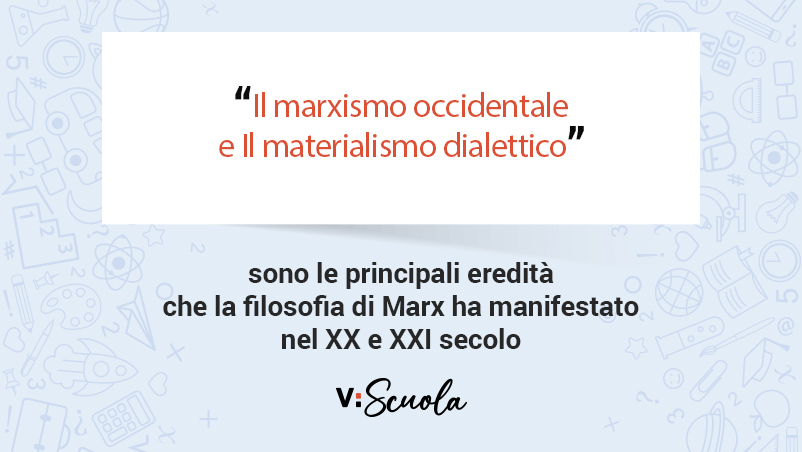
Il materialismo dialettico
Il materialismo dialettico, invece, è una teoria dialettica della natura e della storia che si fonda sul metodo dialettico di Hegel, utilizzato tuttavia in chiave materialista. In altre parole, è la “concezione filosofica” del marxismo così come è stata sviluppata, soprattutto, da Engels e Lenin, e che è stata a lungo considerata la “filosofia ufficiale” dell’Unione Sovietica e di altri Paesi socialisti. Si tratta di una dottrina che può essere definita “della materia in movimento”, oltre che “logica della contraddizione”. Il termine “dialettico” indica l’inclusione nel punto di vista materialista della consapevolezza della dinamica interconnessione tra i processi e dell’universalità del mutamento: pertanto, secondo questa dottrina, qualsiasi ente è soggetto a un processo di autotrasformazione, in relazione al fatto che il suo contenuto è costituito da forze in opposizione (e, quindi, nel gergo hegeliano, “contraddittorie”). Ciascuna cosa, quindi, muta costantemente in qualcosa di diverso da sé e, in tale contesto, vengono ripudiati il meccanicismo, inteso come materialismo non dialettico, e la metafisica, nella sua accezione di ontologia idealista. Secondo questo punto di vista, il materialismo storico coinciderebbe con l’applicazione del materialismo dialettico alla storia delle società umane. Sebbene i marxisti, e specialmente Marx stesso, si siano occupati soprattutto del materialismo storico, è possibile rintracciare un’importante elaborazione teorica di carattere marxista anche riguardo alla storia naturale che, secondo la filosofia materialista, abbraccerebbe al proprio interno anche la storia dell’umanità. Ma fu basandosi sulla dialettica hegeliana, e quindi sulla visione dialettica della storia come continuo evolversi dei rapporti servo-padrone, che Marx formulò il materialismo dialettico, che mantenne questa concezione dialettica della storia, liberandola tuttavia del suo idealismo, che considera la dialettica come frutto dello scontro delle idee intese nel senso filosofico letterale, cioè i valori assoluti ed esistenti su un piano d’esistenza ideale e pertanto assoluto. Marx introdusse una concezione materialistica della dialettica, applicandola poi alla concezione della storia (il cosiddetto materialismo storico) intesa come storia umana, interpretandola certamente come frutto di valori e movimenti, inizialmente come conseguenza delle condizioni materiali che li generano. Tali condizioni materiali sono, prima di tutto, determinate dal sistema economico, che nell’analisi marxiana costituisce la struttura sulla quale si costruisce la sovrastruttura in ogni sua forma.
