L'Etica del dovere e la missione dell'umanità: Fichte
Le polemiche sull'ateismo contribuirono a una svolta del suo pensiero in una direzione più ontologica e religiosa
L’Etica del dovere
Per Johann Gottlieb Fichte, l’opposizione tra Io e Non-Io riguarda non solo l’ambito teoretico, ma anche quello pratico. In questo secondo caso, tuttavia, è importante porre l’attenzione nell’azione inversa: quindi, non quella del Non-Io sull’Io, che nello sviluppo del discorso sembra inizialmente essere passivo, ma dell’Io sul Non-Io o, meglio ancora, dell’Io come determinante il Non-io. Quest’azione dell’Io sul Non-Io, infatti, viene definita da Fichte come uno sforzo, inteso come la capacità del soggetto di opporre resistenza alla materia considerata come ciò che ostacola il soggetto stesso nel raggiungimento di una purezza della volontà razionale. Pertanto, il supremo valore morale non è altro che la libertà che, però, non potrà mai essere definitivamente raggiunta poiché, tutte le volte in cui l’Io vincerà sul Non-io, ne creerà inconsciamente un altro. La morale di Fichte si racchiude all’interno di un’etica dell’azione e l’attività pratica diventa la “vera missione dell’uomo”, capace di superare – in importanza – quella teoretica: proprio per questo motivo, quello fichtiano, è stato ribattezzato “idealismo etico”. Ad ogni modo, bisogna evidenziare che non può esserci attività pratica senza che il soggetto determini se stesso e ciò che lo circonda, per cui – molto spesso – l’importanza dell’azione dell’Io coincide con il valore pratico di un puro atto di pensiero. Da qui deriva anche il concetto di male: non si tratta di un principio metafisico (inteso come mancanza del bene), ma va considerato come una carenza di azione, ossia l’accidia. Infatti, per Fichte non esiste niente di peggio che perdersi nel piacere fine a se stesso. All’etica illuministica fondata sulla felicità e sull’obbedienza alla natura, Fichte oppone un’etica del sacrificio.
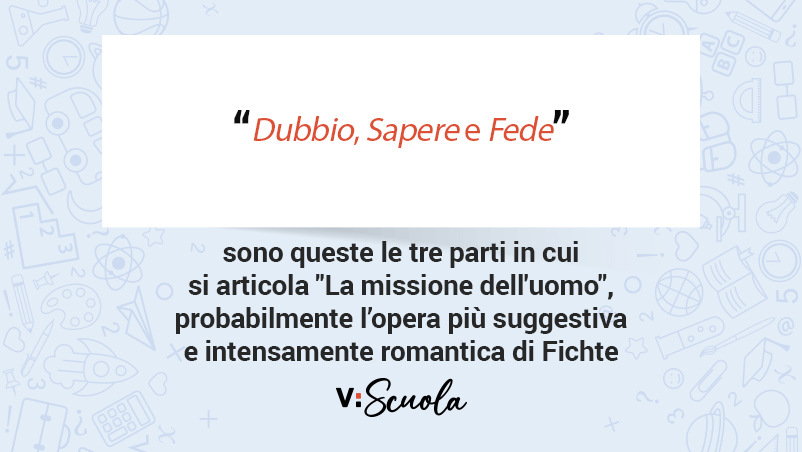
La missione dell’uomo
‘La missione dell’uomo’, probabilmente l’opera più suggestiva e intensamente romantica di Fichte, datata 1800, è il testo che segna il passaggio alla sua ‘seconda filosofia’. Essa venne redatta a Berlino, dopo il conflitto suscitato dalle accuse di ateismo che avevano spinto il filosofo tedesco ad abbandonare la cattedra presso l’Università di Jena, oltre che a seguito di alcuni dissapori con Schelling, che lo stava via via offuscando e gli contestava un eccessivo soggettivismo. I suoi toni religiosi, infatti, costituiscono una replica proprio a tali accuse. Si articola in tre parti: “Dubbio”, “Sapere” e “Fede”, intese come le tappe di un ideale cammino dalla vita naturale a quella spirituale. Nei tre libri Fichte raccoglie i risultati della polemica sull’ateismo in cui venne coinvolto negli ultimi del Settecento e costituisce una sorta di ponte di passaggio alle esposizioni ulteriori della Dottrina della scienza. Ne ‘La missione dell’uomo’ il filosofo tedesco descrive la liberazione dell’uomo dalla costrizione del mondo naturale mediante la scienza e, quindi, il passaggio dalla scienza alla Fede. Infatti, secondo quanto affermato dallo stesso Fichte, dando realtà alle cose, essa impedisce a quest’ultime di essere delle vane illusioni: in altre parole, si tratta di quella che può essere definita “la sanzione della scienza”. In altre parole, quindi, si potrebbe descrivere il suo pensiero asserendo che, in realtà, non esiste davvero una scienza, ma soltanto alcune determinazioni della volontà che si danno per scienza, in quanto è la Fede che le costituisce come tali. È importante sottolineare che la ‘svolta ontologico-religiosa’ non fece sì che il filosofo abbandonasse il suo precedente punto di vista.
